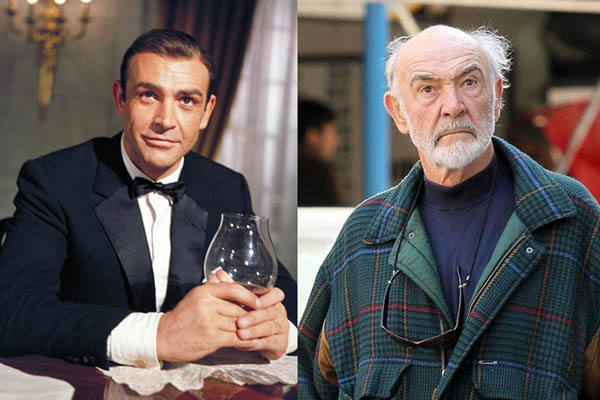LA BALLATA DI BUSTER SCRUGGS
di Barbara Rossi
da “I DIARI DI CINECLUB, n.68, gennaio 2019 (puoi scaricare gratuitamente l’ultimo numero della rivista cliccando QUI)
Lacrime più copiose gli velarono gli occhi e nella penombra gli parve di vedere la figura di un giovane in piedi, sotto un albero grondante di pioggia. Altre figure gli erano vicine. La sua anima aveva avvicinato la regione in cui dimora la folla sterminata dei morti. Ne era cosciente, ma non riusciva a coglierla, quella loro effimera e tremolante esistenza. La sua stessa identità si stava smarrendo in un mondo grigio e impalpabile, e lo stesso mondo materiale, il mondo sul quale quei morti avevano vissuto e procreato si andava dissolvendo e rimpicciolendo.
(James Joyce, I morti – Gente di Dublino)
La ballata di Buster Scruggs riporta alla mente la riflessione sulla morte, sotto forma di elegia commossa e malinconica, al centro del racconto più lungo della raccolta Gente di Dublino (1914) di Joyce; oppure – non a caso pubblicata all’incirca nel medesimo periodo, tra il 1914 e il 1915 – L’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, rievocazione del senso e non senso della vita attraverso la declinazione in chiave poetica di epitaffi tombali.
Nell’ultimo lungometraggio dei fratelli registi di Minneapolis, presentato lo scorso settembre in concorso al Festival del Cinema di Venezia e vincitore del premio per la migliore sceneggiatura (fruibile, non senza il consueto corollario di polemiche, dalla piattaforma digitale Netflix, per cui era stato originariamente ideato in forma di serie), è il sentimento della fine ad aleggiare, a tratti leggero, indefinito e surreale, a tratti in una forma brutalmente esplicita, frazionato nei sei episodi.

I Coen, a questo proposito, chiariscono le ragioni della struttura a episodi sostenendo che «Ci sono sempre piaciuti i film antologici, in particolare i film girati in Italia negli anni Sessanta, che mettevano insieme opere di diversi registi incentrate su uno stesso tema.» Qui l’omaggio non è soltanto alle produzioni antologiche italiane espressione di una determinata fase del nostro cinema, ma anche e soprattutto a un genere – il western – da considerarsi fondativo del grande apparato illusionistico della cinematografia americana classica.
Non si tratta però di un western rivisitato più o meno fedelmente, e neppure di un tentativo di ribaltamento parodico dei suoi canoni: l’ironia c’è, come di consueto nel cinema dei Coen, ma al solito corrosiva, amarissima, tragica. Il genere declinato dai registi nel film è del tutto depauperato, svuotato della sua essenza, di cui non restano che i luoghi comuni, gli archetipi che lo hanno connotato e reso riconoscibile al grande pubblico.
I canyon sterminati, le piste attraversate dalle lunghe fila di carovane, le nubi di polvere sollevate dagli zoccoli dei cavalli, i cowboy e i fuorilegge, i saloon, gli uffici postali e i postriboli, le stazioni di posta sono ridotti a figurine di cartapesta animate contro uno sfondo artefatto: proiettate verso il nulla, come l’esistenza umana. La rottura della quarta parete, le interpellazioni degli attori agli spettatori, con lo sguardo dritto in macchina, non fanno che accrescere la percezione di rottura dell’illusione scenica, scardinando dall’interno la finzione narrativa. Il western è morto, e con esso anche l’eroismo dei primi pionieri, la giustizia trionfante, l’happy end salvifico e consolatorio.
Perfino la manicheistica separazione narrativa tra bene e male, tra giusto e sbagliato viene a cadere: i buoni sembrano cattivi e i cattivi buoni; le brave fanciulle, i leggendari pistoleri dalla mano lesta, gentiluomini e delinquenti, giovani e vecchi, onesti e ladri, sani e malati, tutti sono destinati all’appuntamento finale con la nera mietitrice.

Nel cinismo assurdo con cui si esprime l’assurdità dell’universo «solo della fine ci è stata concessa certezza» come ricorda il conducente di carovane Billy Knepp a miss Alice Longabaugh, nel corso del penultimo episodio del film (La giovane che si spaventò) . I Coen approdano con La ballata di Buster Scruggs a una sorta di pessimismo cosmico di matrice leopardiana, che diviene sempre più tragico mano a mano che – proprio come le pagine consunte di un vecchio libro di racconti western – si avvicendano
le sei antiepiche narrazioni (emblematico e letteralmente luciferino risulta, a questo proposito, l’ultimo episodio, Le spoglie mortali), edificate sulla precarietà del mondo.
Dentro questo nulla privo di speranza anche la Natura, in terribilità o splendore, si rivela silente testimone dell’insignificanza dell’umano: “pioppi e pini si ergevano lungo il percorso, spettatori indifferenti del passaggio dell’uomo”. Magnifica, anch’essa smaccatamente artificiosa, la fotografia (vedi, ad esempio, le molteplici tonalità di verde nella prateria che fa da sfondo al quarto episodio, Il canyon tutto d’oro), dolenti e suggestive le ballate country, espressivi e carismatici gli attori, specialmente il James Franco-Buster Scruggs dell’episodio d’apertura, l’Harry Melling artista disabile del terzo (Il
tordo senza ali) e il Tom Waits vecchio cercatore d’oro nella già citata quarta storia.
In una pellicola interamente giocata in chiave antinarrativa, l’incipit, in fondo, contiene già in sé l’inevitabile chiusa, condensata nel saluto alla vita in voce off dell’eccentrico, un tempo temibile Buster: «Dev’esserci un posto nell’aldilà in cui gli uomini non sono carogne e a poker non si bara. Se non ci fosse, di cosa parlerebbero le canzoni? Vi aspetto tutti lì. Così canteremo insieme scuotendo la testa davanti alla cattiveria che avevamo quaggiù.»
®Riproduzione Riservata

PUOI SCARICARE L’INTERA RIVISTA GRATUITAMENTE CLICCANDO QUI!